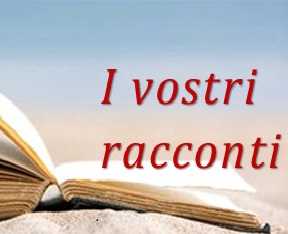COSENZA, 10 ottobre 2023 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sant’Agata di Esaro (Cs) da mercoledì 11 ottobre, sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
COSENZA, 10 ottobre 2023 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sant’Agata di Esaro (Cs) da mercoledì 11 ottobre, sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La sede della provincia di Cosenza infatti è stata inserita nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Sant’Agata di Esaro la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato preso l’ufficio postale di San Sosti aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12,35.
La sede temporanea di via G. Matteotti è dotata anche di un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.
Poste Italiane – Media Relations
 A tutte le Amministrazioni Regionali, Provinciali e comunali, all’inizio del loro percorso socio-politico, il Ministero dell’Interno e quello della Istruzione dovrebbero IMPORRE un vademecum sul loro prossimo impegno. In particolare portare a loro conoscenza, oltre a ciò che tradizionalmente sono le attività da svolgere, aggiornare lor signori su alcune “aggiunte” alla Nostra Carta Costituzionale e in particolare al nuovo comma inserito nell’art. 33 della Carta Costituzionale che persegue il fine di tutelare l’attività sportiva come strumento di sviluppo della persona.
A tutte le Amministrazioni Regionali, Provinciali e comunali, all’inizio del loro percorso socio-politico, il Ministero dell’Interno e quello della Istruzione dovrebbero IMPORRE un vademecum sul loro prossimo impegno. In particolare portare a loro conoscenza, oltre a ciò che tradizionalmente sono le attività da svolgere, aggiornare lor signori su alcune “aggiunte” alla Nostra Carta Costituzionale e in particolare al nuovo comma inserito nell’art. 33 della Carta Costituzionale che persegue il fine di tutelare l’attività sportiva come strumento di sviluppo della persona.
Rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra, in poche parole, un significato profondo e un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell'auspicio dello ‘sport per tutti e di tutti’, parte delle indispensabili ‘difese immunitarie sociali’ e importante contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.
Oggi nella società globalizzata, certamente più libera ma più incerta, in cui l’individuo è costretto a cambiare ruolo assiduamente ed a vivere ambiti diversi e diversamente regolati, lo sport rappresenta la metafora giusta per adattarsi a questi continui cambiamenti.
Sappiamo come nel tempo lo sport ha cambiato i suoi significati: da vigoria del corpo ad immortalità dell’anima, a competizione, a manifestazione come intrattenimento per liberare le tensioni e le emozioni. Inoltre abbiamo imparato che lo sport è anche altro. Lo sport insegna ad accrescere relazioni sociali, integrazione, inclusione, controllo intellettuale; le sue regole a sviluppare amicizia,dove sacro è il rispetto e la fiducia, confronto con l’avversario come spinta ad esprimere le proprie potenzialità, spirito di squadra per uno scopo comune, lealtà nel saper perdere ma principalmente nel saper vincere, in modo corretto.
Lo sport inteso come gruppo sociale, organizzato intorno a delle regole che facilitano la conoscenza dei propri ritmi, delle proprie capacità; come sana competizione, utile ad orientare le nostre scelte e le nostre priorità in ordine di importanza; come disciplina per il raggiungimento di ottimi risultati e di un eccellente equilibrio psico-fisico; come educazione alla socializzazione dei giovani, nel tentativo di creare futuri spettatori integri e maturi per tentare di arginare la violenza ed il razzismo.
Lo sport previene, specialmente tra i bambini e i giovani, i comportamenti a rischio come l'uso di sostanze stupefacenti, alcol, diete non sane e atteggiamenti violenti e favorisce il benessere psicologico,
attraverso lo sviluppo dell'autostima, dell'autonomia e facilitando la gestione dell'ansia e delle situazioni stressanti.
Gigino A Pellegrini & G elTarik
 Si sente parlare sempre più spesso del "pensiero critico" come di una capacità apprezzabile per vivere nel mondo moderno, ma pochi sanno cosa esso sia.
Si sente parlare sempre più spesso del "pensiero critico" come di una capacità apprezzabile per vivere nel mondo moderno, ma pochi sanno cosa esso sia.
La conseguenza pratica è che la maggior parte delle persone trova facile mettere in discussione soltanto quelle credenze, assunzioni e deduzioni che hanno già “rifiutato” e trovano invece molto difficile, in alcuni casi anche traumatico, mettere in discussione quelle credenze sulle quali hanno investito personalmente, egocentrici.
Non so se esiste un modo di insegnare il pensiero critico e far sì che la persona prima impari a riconoscere ipotesi e deduzioni discutibili in casi “egocentricamente” neutri e poi “trasferisca” automaticamente quelle abilità a quelli egocentrici e socio centrici.
Ci troviamo di fronte a persone al potere, che hanno già sviluppato una buona serie di ipotesi distorte, stereotipi, credenze egocentriche e socio centriche, addestrandosi a riconoscere ragionamenti “cattivi” in casi “neutri” diventano più, e non meno, sofisticati: più abili nel “razionalizzare” e “intellettualizzare” i pregiudizi che già hanno. È quindi meno probabile che li abbandonino se in un secondo momento incontrano qualcuno che fa loro delle domande senza ottenere nessuna risposta.
Crollato il Muro di Berlino, il solo capitalismo rimase a forgiare la vita sociale dell’Occidente. Però, già nel 1974, il filosofo Karl Popper riconduceva l’inconciliabilità reale di socialismo e libertà individuale alla impossibilità di realizzare l'uguaglianza senza sacrificare la libertà come condizione dell’uguaglianza e scriveva “Per diversi anni rimasi socialista, anche dopo il mio ripudio del marxismo; e se ci fosse stato qualcosa come un socialismo combinato con la libertà individuale sarei ancor oggi un socialista….”Abbiamo bisogno della libertà per impedire che lo Stato abusi del suo potere e abbiamo bisogno dello Stato per impedire l’abuso della libertà”.
Infatti, nel secolo appena passato si sono avvertite le profonde lacerazioni e tensioni tra Stato e cittadino, tra ordine e libertà, tra legge e diritto, e, in buona sostanza, tra ideologia e verità. La conclusione dell’esperimento di socialismo reale nei paesi dell’Est Europa era stata salutata dal politologo Francis Fukuyama come “la fine della storia”. Dopo aver prevalso su modelli di Stato e concezioni di democrazia avversarie, la liberal-democrazia si avviava a rappresentare l’unico orizzonte istituzionale rimasto.
L’Unione europea ha deciso di privilegiare il mercato unico, rifiutando lo Stato unitario e cerca di mantenere in vita una democrazia priva delle sue proprie basi. E’ una scelta, non un frutto di natura. Lo stesso dicasi per la Cina che privilegia lo Stato, accetta il mercato e rifiuta la democrazia, almeno nella sua versione ortodossa.
Il Regno Unito, con la Brexit, ha privilegiato la democrazia, rifiutato il mercato comune e confermato l’importanza dello Stato. Gli Stati Uniti sono il paese che ha cercato di contrastare l’inconciliabilità, ma la campagna elettorale in corso apre scenari preoccupanti da questo punto di vista.
Gigino A Pellegrini & G elTarik